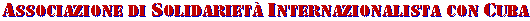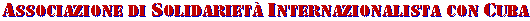America latina, lucrosa retrovia per gli Stati uniti
di
James Petras e
Todd Cavalluzzi*
Molte ragioni vengono addotte per spiegare le politiche di
liberalizzazione che si sono generalizzate in America latina
nell'ultimo decennio. Per alcuni esisterebbe un ciclo
nazional-populista che comincia con l'intervento dello stato, le
nazionalizzazioni e il protezionismo, si consolida con una
strategia di sostituzione delle importazioni, poi entra in crisi
a causa della crescita dei deficit pubblico e commerciale, degli
squilibri macroeconomici e del declino della competitività.
Tutto ciò aprirebbe la strada alla "rivoluzione liberale".
Altro tipo di argomentazione: l'emergere, negli anni 70, di una
classe di capitalisti latino-americani transnazionali, legati al
mercato mondiale, che avrebbero beneficiato di politiche
pubbliche di sostegno alle esportazioni e sarebbero diventati
gli strateghi della liberalizzazione. Una terza scuola di
pensiero mette l'accento sull'indebitamento estero e
sull'influenza e le pressioni della Banca mondiale e del Fondo
monetario internazionale (Fmi) nell'imporre misure liberali come
contropartita al rifinanziamento del debito.
Altri analisti privilegiano i conflitti di classe e le modifiche
dei rapporti di forza avvenuti tra esse, sia sul piano estero
che interno. In questa ottica, la coalizione costituitasi tra
borghesia nazionale, classe operaia e contadini, base sociale
della politica di sostituzione delle importazioni, si sarebbe
disgregata in seguito alla compressione degli utili delle
imprese e delle risorse dello stato, e avrebbe ceduto il posto a
una nuova coalizione di regimi militari associati alla borghesia
esportatrice, partner essa stessa delle ditte multinazionali.
Contemporaneamente, il crollo dei regimi "socialisti" europei
eliminava possibilità di finanziamenti e di sbocchi alternativi,
costringendo i regimi latino-americani ad adattarsi alle
esigenze del solo potere mondiale rimasto, quello dei paesi a
capitalismo avanzato.
Indiscutibilmente, ciascuna di queste spiegazioni contiene una
parte di verità. Ma ce n'è anche un'altra che sembra aver avuto
un ruolo determinante: le esigenze della strategia economica
degli Stati uniti. Il primo dato evidente del mondo
postcomunista è, infatti, la concorrenza tra Stati uniti,
Germania e Giappone per il controllo dei mercati mondiali.
Ognuna di queste superpotenze si è ritagliata delle zone
d'influenza che le permettono di produrre con spese minori
rispetto alle sue concorrenti. Negli ultimi due decenni, gli
Stati uniti hanno perso i propri vantaggi comparativi in settori
come l'automobile e l'elettronica, anche se sembra avviarsi una
inversione di tendenza. Ne consegue l'accumulo di enormi deficit
commerciali con il Giappone (e altri paesi asiatici) e, in
misura minore, con la Germania.
Il progressivo ritiro delle truppe americane dall'Europa e dal
Giappone priva Washington di mezzi di pressione
politico-economici, pressione fino ad allora esercitata tramite
la Nato e altre alleanze militari. Quanto alle minacce di guerra
commerciale, si rivelano a doppio taglio, perché possono avere
conseguenze negative per gli esportatori, gli importatori e per
i consumatori americani di prodotti stranieri a buon mercato. La
linea di minor resistenza e nello stesso tempo la più conforme
alla storia americana (dottrina Monroe, Unione panamericana,
Alleanza per il progresso) è quella di una strategia di blocco
regionale dove gli Stati uniti, in quanto potenza egemonica,
possono trarre dall'America latina il massimo di utili
attraverso commercio, investimenti, interessi e canoni.
Da questo punto di vista, il sud del Rio Grande e il Canada
costituiscono terreni privilegiati per l'accumulazione e il
rimpatrio di utili, interessi e canoni verso gli Stati uniti,
compensando, in parte, i deficit commerciali con l'Asia e
l'Europa occidentale. I bassi costi di produzione (grazie alla
mano d'opera a buon mercato del Messico e dei Caraibi)
permettono ai produttori americani di mantenere la loro
competitività sia all'estero che sul mercato interno. In questo
senso, la liberalizzazione dell'America latina è intimamente
legata agli interessi mondiali degli Stati uniti.
Questa liberalizzazione è stata portata avanti sotto l'egida del
Fmi e della Banca mondiale, su istigazione dei rappresentanti di
Washington che ne fanno parte. Per un certo periodo, i dittatori
latino-americani favorevoli alla liberalizzazione hanno ricevuto
finanziamenti e appoggio politico. Poi la Casa bianca ha
utilizzato i suoi buoni uffici per favorire transizioni
elettorali, nella misura in cui, però, i nuovi regimi
democratici s'impegnassero ad approfondire una liberalizzazione
che avrebbe favorito essenzialmente banche e multinazionali
americane e, complessivamente, l'insieme dell'economia degli
Stati uniti. E' questo che spiega la battaglia condotta dai
negoziatori di Washington per includere la proprietà
intellettuale nell'Atto finale del ciclo dell'Uruguay
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio
(Gatt). I canoni su diritti di sfruttamento, brevetti e marchi
sono una voce importante della bilancia dei pagamenti degli
Stati uniti: tra il 1972 e il primo trimestre del 1992 sono
aumentati fino a 1,06 miliardi di dollari. Mentre la loro media
annua dal 1962 al 1971 era di soli 52,6 milioni di dollari, nel
1992-1993 sono passati ad una media di 189,8 milioni di dollari.
I diritti di sfruttamento e i canoni costituiscono una forma di
rendita di cui si misura meglio l'importanza nei conti esteri
degli Stati uniti quando la si confronta ai redditi degli
investimenti diretti in America latina. Tra 1961 e 1971, questa
rendita ne rappresentava un terzo - 26 milioni di dollari contro
76 milioni di dollari -, per precipitare a un 6% tra 1972 e 1981
(242 milioni di dollari contro 4,176 miliardi di dollari). Nel
periodo 1982-1991, c'è una inversione del bilanciere: i diritti
di sfruttamento e i canoni hanno reso 395 milioni di dollari,
mentre gli investimenti diretti nel subcontinente non
procuravano che perdite. Considerando insieme il 1992 e il 1993,
questa voce (379 milioni di dollari) supera di tre volte quella
del rimpatrio degli utili.
In venti anni, dal 1962 al 1981, le multinazionali insediate in
America latina hanno inviato 4,25 miliardi di dollari sotto
forma di retribuzioni, utili distribuiti e non distribuiti ma
reinvestiti. Dopo questo periodo di espansione, la depressione
mondiale del 1982, la crisi dovuta all'indebitamento e le misure
di adeguamento strutturale hanno contratto i mercati
latino-americani, poiché le risorse erano canalizzate a favore
del debito. Al punto da provocare non solo un crollo brutale dei
redditi da investimenti, ma anche perdite: 373,9 milioni di
dollari tra il 1982 e il 1991... Ma questo indebitamento ha
fornito alla Banca mondiale e al Fmi un argomento forte per
chiedere la privatizzazione delle imprese pubbliche, molte delle
quali sono state ricomprate da multinazionali americane.
Con la timida ripresa economica successiva, i versamenti di
utili agli Stati uniti sono ripresi: 150 milioni di dollari tra
il 1992 e il primo trimestre del 1994. Come si vede, la crisi
del debito e le politiche di adeguamento strutturale non hanno
avuto effetti negativi solo sulle economie del subcontinente:
esse hanno assottigliato i trasferimenti di utili delle
multinazionali americane.
Tuttavia la fonte principale di flussi finanziari privati
dall'America latina verso gli Stati uniti consiste nei pagamenti
di interessi, in progressione massiccia dopo il rialzo dei tassi.
Complessivamente questi trasferimenti hanno raggiunto 233
miliardi di dollari tra il 1972 e il 1992, con le conseguenze
nefaste che si possono immaginare sulla crescita delle economie
locali, importazioni e domanda interna.
Le eccedenze commerciali mettono in evidenza un'altra dimensione
dell'asimmetria delle relazioni tra gli Stati uniti e i loro
vicini e spiegano il sostegno di Washington agli accordi di
"libero scambio". Come media annuale, questa eccedenza ha
raggiunto i 426 milioni di dollari tra il 1962 e il 1971 e i
4,34 miliardi di dollari tra il 1972 e il 1981, per trasformarsi
in deficit a partire dal 1983: 1,725 miliardi di dollari tra il
1982 e il 1992. Era la conseguenza diretta delle "strategie di
esportazione" imposte dalle istituzioni finanziarie
internazionali ai governi latino-americani affinché
accumulassero utili da destinare al pagamento del debito.
Tuttavia le perdite di mercati non sarebbero state che
temporanee, l'eliminazione delle barriere doganali avrebbe in
seguito permesso una penetrazione americana più forte che mai.
Con l'aiuto della ripresa economica, le eccedenze sono
ricominciate: 2,25 miliardi di dollari in media nel 1992 e 1993.
Se si sommano le tre sorgenti di reddito che gli Stati uniti
traggono dall'America latina (rendita, interessi e eccedenze
commerciali) e si mettono a confronto con i deficit commerciali
che risultano dagli scambi con Germania e Giappone, si valuta
meglio l'importanza del subcontinente. Tra il 1962 e il 1971,
questi utili hanno rappresentato i tre quarti del deficit col
Giappone e il doppio di quello contratto con la Germania. Tra il
1972 e il 1981 queste entrate hanno equilibrato il saldo
negativo con Tokio. Negli anni 1982-1991, l'eccedenza è
raddoppiata ma, nello stesso periodo, il deficit con il Giappone
è più che quintuplicato e quello con la Germania è aumentato del
700%. Questa è la struttura che sembra conservarsi attualmente.
L'America latina costituisce una posta importante per gli Stati
uniti, visto che permette loro di compensare una parte degli
squilibri commerciali con le altre due grandi potenze economiche
e attenua così il declino della loro posizione mondiale.
note:
* Rispettivamente professore di sociologia e ricercatore
all'università dello Stato di New York a Binghamton.
Articolo tratto da Le Monde Diplomatique del febbraio-1995, inserto mensile de il manifesto