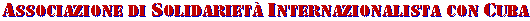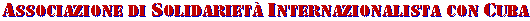LE MULTINAZIONALI
IMPONGONO LA LORO LEGGE
Globale e informale,
torna il colonialismo
Stiamo assistendo a una nuova fase della storia coloniale? Le
società industriali hanno praticato, nel XIX secolo, una
politica dapprima di conquista dei mercati del Sud, poi di
occupazione militare, infine di annessione. Nel corso della
seconda metà del XX secolo, dopo le proclamazioni di
indipendenza, le cosiddette politiche di "sviluppo" sono state
forme inedite di controllo e di assoggettamento. Oggi,
nell'epoca della mondializzazione, un nuovo tipo di colonialismo
prende vigore; non è più diretto, come una volta, dagli Stati,
ma dai giganti multinazionali.
di edward goldsmith*
La vecchia idea di un modello di sviluppo sociale simile a
quello dell'embrione, che porterebbe, in modo crescente e
ininterrotto, da una condizione di assoluta povertà a uno stato
di prosperità generale, è, come ogni altra forma di messianismo,
più pericolosa di quanto sembra. Un economista francese,
François Partant, sembra essersene accorto: "Le nazioni
sviluppate hanno trovato una nuova missione da adempiere:
aiutare i paesi del terzo mondo ad avanzare sulla via dello
sviluppo, la via che da secoli l'Occidente cerca di imporre al
resto dell'umanità (1)".
Un rapido esame della situazione del Sud mostra incontestabili e
preoccupanti elementi di continuità tra l'era coloniale e la
situazione attuale: nessuna revisione di frontiere per paesi di
recente indipendenza, nessun tentativo di ripristinare modelli
culturali pre-coloniali, nessuna modifica delle pratiche
coloniali di gestione delle terre. I contadini poveri, che
"identificavano la lotta per l'indipendenza con quella per le
terre", non hanno ottenuto neanche dei piccoli campi da
coltivare. "Con l'indipendenza nazionale si è assistito alla
conquista delle terre da parte di un nuovo tipo di coloni (2)".
E', osserva il saggista Randall Baker, "per definizione, la
storia di una continuità (3)".
I due termini "sviluppo" e "colonialismo" (almeno nella sua
ultima fase, dopo il 1870) stanno forse a indicare un solo e
unico fenomeno, e quindi un solo obiettivo da perseguire? Si può
ritenere di sì, se si pensa che di un simile obiettivo hanno
parlato, senza peli sulla lingua, alcuni dei suoi più sfegatati
sostenitori. Così dichiarava infatti Jules Ferry, a Parigi, alla
Camera dei deputati, nel giugno del 1885: "La questione
coloniale in un Paese come il nostro, in cui, per il suo stesso
carattere, l'industria è legata a considerevoli esportazioni, è
vitale per la conquista dei mercati. Da questo punto di vista (),
la fondazione di una colonia equivale alla creazione di un
mercato". Paul Leroy-Beaulieu, autore di un libro di grande
successo, De la colonisation chez les peuples modernes, nel
1874, diceva esattamente le stesse cose, come Cecil Rhodes o
Lord Lugard in Inghilterra.
Eppure, parecchi paesi del terzo mondo, soprattutto asiatici,
non erano affatto felici di offrire alle grandi potenze
occidentali né i loro mercati, né la loro manodopera a basso
costo, né le loro tanto desiderate materie prime. In nessun modo
volevano permettere che delle industrie straniere operassero sul
loro territorio e aprissero grandi cantieri di "sviluppo" della
rete stradale o delle miniere.
I paesi colonialisti cominciarono allora a esercitare pressioni
di ogni tipo: ci sarà bisogno di due guerre, per esempio, per
costringere la Cina ad aprire le sue porte al commercio inglese
e a quello francese. Lo sviluppo del commercio finì per rendere
necessaria l'imposizione di concessioni via via più ampie,
creando condizioni sempre più favorevoli per le imprese europee.
Se l'opposizione locale era troppo forte, se un governo
nazionalista o populista arrivava al potere, le potenze europee
ricorrevano semplicemente all'occupazione militare e
all'annessione. "Il colonialismo scrive uno storico britannico
non era una scelta, ma un'ultima risorsa (4)".
L'impatto del colonialismo e dei valori occidentali ha prodotto
un progressivo sfaldamento delle società tradizionali, in Africa
come in Asia. Tutto ciò ha facilitato il mantenimento di
condizioni favorevoli al commercio e alla penetrazione
dell'Occidente. Verso la metà del XX secolo, all'epoca della
decolonizzazione e delle indipendenze, gli investitori e i
commercianti europei poterono infine "agire con loro piena
soddisfazione nel quadro politico della maggior parte degli
stati indigeni ricostruiti (come avevano sognato di fare i loro
predecessori nel XIX secolo) senza peraltro dover
necessariamente affrontare i problemi legati al sistema, in
passato indispensabile, della dominazione diretta (5)".
Detto in altri termini: il colonialismo non è morto per la
rinuncia da parte delle potenze europee ai vantaggi che
procurava, ma piuttosto perché ormai esse erano in grado di
ottenere i medesimi vantaggi con metodi più accettabili e più
efficaci. Questo è quanto pensavano i diplomatici e i dirigenti
economici che si sono riuniti a Washington fin dal 1939, sotto
l'egida dell'U.S. Council on Foreign Relations. Essi cercavano i
mezzi più efficaci per riuscire, a guerra finita, a piegare
l'economia mondiale post-coloniale agli interessi del commercio
americano. Queste discussioni portarono alla famosa conferenza
di Bretton Woods del 1944 (6), nel corso della quale furono
fondati la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale
(Fmi).
Il libero scambio, si diceva, equivaleva a "una competizione in
condizioni di pari opportunità", senza svantaggi sleali. Ma,
quando il forte attacca il debole, anche se con pari opportunità,
il risultato della partita non è forse già deciso in anticipo?
All'epoca di Bretton Woods, gli Stati uniti controllavano
incontrastati la sfera politico-economica mondiale, l'Europa
industriale era devastata dalla guerra e il Giappone era stato
conquistato e sottomesso.
Un secolo prima, era stata l'Inghilterra a decantare le lodi del
libero scambio, e per le stesse ragioni: poiché gli inglesi
dominavano l'economia mondiale, il libero scambio era funzionale
ai loro obiettivi commerciali. Dal 1860 al 1873, Londra è
riuscita a creare il primo nucleo di un "sistema mondiale
universale di flussi virtualmente illimitati di capitali, merci
e lavoratori", constata lo storico britannico Eric Hobsbawm.
Solo gli Stati uniti sono rimasti sistematicamente legati a una
politica protezionistica, riducendo i loro dazi doganali solo
dal 1832 al 1860 e poi dal 1861 al 1865, dopo la guerra di
Secessione.
Verso il 1870, l'Inghilterra ha cominciato a perdere terreno
rispetto ai suoi concorrenti. I valori delle sue esportazioni
hanno subito un tracollo una prima volta dal 1870 al 1893, e poi,
nuovamente, alla fine del secolo. Contestualmente, le crisi
prolungate degli anni 1870 e 1890, facevano crescere lo
scetticismo nei confronti della reale efficacia del libero
scambio. Soprattutto nell'ultimo decennio del secolo, i paesi
europei, fatta eccezione per l'Inghilterra, il Belgio e i Paesi
Bassi, hanno aumentato i loro dazi doganali. Vedendo
restringersi i loro mercati tradizionali, le grandi imprese
hanno cominciato a rivolgere i propri interessi verso quelli
dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina e del Pacifico, resi
accessibili dalla navi a vapore rapide e di grosso tonnellaggio.
Per questo, si rendeva necessario conquistare e sottomettere
questi paesi, dove era possibile vendere le proprie merci con
profitto, senza il pericolo e la preoccupazione della
concorrenza di altri paesi europei (7).
Iniziò allora la corsa alle colonie. Nel 1878, il 67% delle
terre emerse era stato colonizzato dagli europei. Nel 1914, la
percentuale raggiungeva l'84,4%
Il mezzo migliore e più intelligente di attivare un nuovo
mercato era di promuovere la creazione sul posto di élite
occidentalizzate, fedeli a un'idea di progresso economico e
assolutamente indifferenti alle conseguenze nefaste che esso
poteva avere sulla vita della maggior parte dei loro compatrioti.
Quest'analisi è valida anche per la situazione odierna e spiega
perché, come sottolinea François Partant, gli interessi dei
governi dei paesi del Sud restano, "in generale, contrari a
quelli della maggioranza della popolazione (8)".
Le potenze europee erano ben consapevoli della necessità di
creare élite di questo tipo. Dopo la rivolta dell'India del 1857,
il principale argomento di discussione negli ambienti politici
di Londra era capire se, per evitare nuovi disordini, fosse
venuto il tempo di formare un'élite anglicizzata, favorevole al
commercio, o se piuttosto, secondo un'opinione più diffusa, si
dovesse mantenere indefinitamente l'occupazione militare (9).
Queste élite dovevano ovviamente essere armate, in modo da poter
imporre un tipo di sviluppo che comportava necessariamente
l'esproprio o l'impoverimento della maggior parte dei cittadini.
Questo è rimasto uno degli obiettivi principali degli attuali
programmi di aiuto: i due terzi degli aiuti che gli Stati uniti
concedono ai paesi del Sud riguardano l'assistenza in materia di
sicurezza e prevedono, in particolare, un addestramento militare
e trasferimenti di armi (10).
La maggior parte dei governi che hanno beneficiato di questi
aiuti sotto forma di armi e di assistenza militare erano delle
dittature militari. Questo fu il caso, negli anni 60 e 70, del
Nicaragua, del Salvador, del Guatemala, del Cile, dell'Argentina,
dell'Uruguay, del Paraguay, del Brasile e del Perù. Così,
quando un governo ostile agli interessi dell'Occidente giungeva
al potere in America latina, prontamente Washington interveniva
per rovesciarlo. Nel 1954 gli Stati uniti hanno organizzato un
colpo di stato contro il governo guatemalteco di Jacobo Arbenz,
che aveva nazionalizzato alcune piantagioni di banane
nord-americane. Più volte si è cercato, negli anni 60, di
rovesciare il regime di Fidel Castro a Cuba, organizzando, in
particolare, nel 1961, lo sbarco nella Baia dei Porci; e allo
stesso modo si è agito in Brasile, quando Joao Goulart ha deciso
di promuovere una riforma agraria e di controllare i maneggi
delle multinazionali americane; poi, nel 1965, contro la
Repubblica Domenicana. E ancora, nel 1973, contro il Cile del
presidente Salvador Allende, poi contro il Nicaragua sandinista,
contro Grenada, e anche, nel 1989, contro Panama.
Nello stesso modo, durante l'epoca coloniale, le potenze europee
hanno sempre inviato truppe in aiuto dei regimi vassalli, messi
in pericolo da rivolte popolari. La Francia e la Gran Bretagna
hanno partecipato alla repressione in Cina della ribellione
promossa dal movimento Taiping (1854), e, più tardi (1900) hanno
represso la sedizione xenofoba dei Boxer; nel 1882 Londra ha
inviato truppe per aiutare il viceré Ismail a soffocare la
rivolta nazionalista egiziana.
Ai giorni nostri, le potenze occidentali non si sono comportate
diversamente. Quando, nel 1964, un colpo di stato minacciava il
presidente-dittatore del Gabon, Mba, la Francia si è affrettata
a inviare un reparto di parà per sconfiggere i golpisti. Queste
truppe sono poi rimaste anche a fianco del suo successore, il
presidente Omar Bongo, che il saggista francese Pierre Péan ha
definito come "il rappresentante di un potente gruppo di
francesi che, dopo l'indipendenza, continuano a influire in
maniera sostanziale sulle vicende del Gabon". Gli Stati uniti e
il Regno unito non sono stati da meno nell'ambito delle loro
rispettive aree di influenza (11).
Nella misura in cui le colonie fornivano alla madrepatria un
mercato per le esportazioni industriali, lavoratori a basso
costo e materie prime, esse sottraevano tutto ciò al loro
proprio settore produttivo. In questo modo, la loro economia
interna risultava seriamente indebolita, e le manifatture locali
erano votate alla distruzione. E' così che l'Inghilterra ha
soffocato, in India, ogni possibilità di sviluppo dell'industria
tessile locale, linfa vitale dell'economia del subcontinente.
Nell'Africa occidentale, nel 1905, a ogni manufatto non
proveniente dalla Francia o da un paese soggetto alla sua
dominazione, veniva imposta una tassa che ne aumentava il prezzo
di vendita, provocando in questo modo la rovina dei commercianti
e degli artigiani locali.
Nel dopoguerra, le economie interne di questi paesi hanno
continuato a soffrire della stessa debolezza di prima.
L'Occidente ha a stento autorizzato la produzione di un numero
ristretto di prodotti d'esportazione. L'esempio tipico è lo
zucchero: per la pressione della Banca mondiale, immensi
territori del Sud sono stati destinati alla coltivazione della
canna, mentre l'Unione europea e gli Stati uniti continuavano a
sovvenzionare la propria produzione di zucchero, provocando in
questo modo un tracollo dei prezzi. Come ci si può stupire,
allora, che i termini di scambio con i paesi poveri del Sud si
siano deteriorati?
Nel periodo compreso tra il 1950 e il 1980, appena uno di questi
paesi mostrava l'intenzione di voler diversificare la sua
produzione, subito veniva accusato di voler promuovere una
strategia di "sostituzione delle importazioni", pratica
considerata peccaminosa, che veniva punita con l'immediato
blocco di ogni prestito di aggiustamento strutturale (Pas) da
parte del Fmi. Del resto, non c'è da sorprendersi se, come nota
Walden Bello (12), "le esportazioni dei paesi sottomessi ai
programmi di aggiustamento strutturale tendono ad aumentare,
senza tuttavia necessariamente generare una crescita del
prodotto interno lordo, a causa della contrazione inevitabile
che colpisce la loro economia".
Accordare ingenti prestiti all'élite complice di un paese non
industriale è il mezzo più efficace per aver accesso, da lontano,
ai suoi mercati e alle sue risorse naturali. Per pagare gli
interessi, infatti, il governo indebitato dovrà investire in
affari che non siano solamente produttivi, ma anche competitivi
sul mercato internazionale, perché i rimborsi vanno fatti in
valuta, generalmente in dollari.
Ahimé! questi governi del Sud avranno molte poche possibilità di
realizzare un tale obiettivo. Circa il 20% della somma presa in
prestito sarà destinato infatti a tangenti riscosse da politici
o da funzionari, altre somme enormi verranno spese per prodotti
di consumo di lusso per l'élite al potere, per infrastrutture
giganti che forse non verranno mai utilizzate, e per le armi
necessarie a soffocare eventuali sedizioni delle popolazioni
vittime di questo tipo di sviluppo. Un paese che fa ricorso a
molti prestiti, si ritrova presto sommerso di debiti e in balia
degli stati creditori. E' a questo punto che questi ultimi
daranno vita a una dominazione di fatto, sottomettendo il
debitore al controllo di un'istituzione (attualmente il Fmi),
che prenderà in mano la sua economia in modo che gli interessi
siano regolarmente pagati. Il paese debitore diviene così una
colonia "informale".
La tecnica del "colonialismo informale" non è nuova. Essa è
spesso stata usata durante l'epoca coloniale, in Egitto come in
Tunisia. Il bey di Tunisi aveva fatto ricorso a molti prestiti
per rinforzare il suo esercito e allentare i legami stretti con
la Turchia. Una quota considerevole della somma presa in
prestito corrispondeva a obbligazioni detenute da cittadini
francesi, che presto invocarono l'aiuto del Quai d'Orsay. Le
loro richieste non rimasero inascoltate. La gestione economica
del bey fu quindi sottomessa a una supervisione tecnica ben
collaudata dalla Francia e dall'Inghilterra, che rappresentava
una sorta di antesignano del Fmi.
La commissione mista franco-tunisina, fondata nel 1869, impose
subito condizioni draconiane. Si assunse il diritto di
raccogliere e distribuire le entrate dello stato, in modo da
garantire il puntuale pagamento degli azionisti. Il presidente
americano Bill Clinton ha appena concluso un'operazione analoga
in Messico, obbligato a mettere un'ipoteca sulla sua principale
ricchezza, il petrolio, da usare come garanzia per i grandi
finanzieri di Wall Street che in cambio hanno accordato un
prestito di diversi miliardi di dollari. Fin dal 1869, "le
finanze pubbliche della Tunisia, e cioè il suo governo di fatto,
sono controllate da stranieri (13)". La Tunisia è diventata così
una "colonia informale". A causa delle sempre più pressanti
richieste di pagamento da parte degli stranieri, il bey dovette
aumentare le tasse, generando un diffuso malcontento nel popolo,
che cominciò ad accusare il governo di essersi venduto agli
stranieri. Nel 1881 ha avuto luogo la vera e propria annessione
(forse effettuata dalla Francia semplicemente per paura di
essere preceduta dall'Italia). Stessa sorte è toccata all'Egitto.
Harry Magdoff l'ha riassunta alla perfezione: "La perdita di
sovranità dell'Egitto ricorda la vicenda tunisina: crediti
facili e prolungati da parte degli europei, bancarotta,
crescente controllo da parte della commissione del debito estero,
sfruttamento dei contadini per raccogliere i fondi necessari
per il servizio sul debito, sviluppo di agitazioni nazionaliste,
conquista militare da parte di un governo straniero (14)".
Nell'epoca dello sviluppo, la tecnica del prestito come mezzo di
controllo si è notevolmente perfezionata. Si nasconde la vera
natura del prestito sotto l'ipocrita definizione di "aiuto",
giustificato dalla "povertà" del terzo mondo, conseguenza del
suo sottosviluppo, rispetto al quale lo sviluppo sembra essere
il palliativo automatico. Per porre rimedio a questa situazione
di sottosviluppo, occorrono capitali e conoscenze tecniche, che
vengono puntualmente forniti dal sistema delle industrie
occidentali. Secondo le parole di John M. Galbraith, "possedendo
il vaccino, abbiamo inventato il vaiolo".
Gli attuali modelli sono i paesi di recente industrializzazione,
come la Corea del Sud, Taiwan, Singapore o Hong-Kong. Singapore
e Hong-Kong non hanno mai contratto molti debiti per finanziare
il loro sviluppo. Taiwan si è indebitata un po', all'inizio, ma
ha saputo resistere alle pressioni esercitate dagli Stati uniti
per indurla a spendere di più. L'unico fra questi paesi ad
essersi indebitato in maniera considerevole è stata la Corea del
Sud. Tuttavia i coreani sono riusciti laddove altri hanno
fallito (cioè a riscattare i propri debiti attraverso le
esportazioni) e semplicemente perché hanno saputo resistere alla
Banca mondiale e al Fmi che li spingevano ad aprire i loro
mercati. In tal modo, essi hanno mantenuto il controllo delle
importazioni e dei capitali, così come precedentemente avevano
fatto i giapponesi. Se è evidente che lo sviluppo ha bisogno di
capitali, nota l'economista Cheryl Payer, "nel mondo attuale,
sono i mercati e non i capitali a costituire una rarità (15)".
Oggi la politica degli aiuti è uno strumento eccellente per
aprire i mercati, visto che una parte significativa
dell'assistenza data è legata all'acquisto di prodotti esportati
dal paese donatore. Come le colonie di una volta, costrette ad
acquistare i manufatti dalla madrepatria, i beneficiari di
crediti sono obbligati a spendere circa il 70% di una somma di
denaro teoricamente destinata a combattere la povertà e la
malnutrizione, per l'acquisto di attrezzature inadatte e
articoli industriali prodotti dai loro generosi donatori. E se
si azzardassero a opporre un seppur minimo rifiuto, la loro
audacia verrebbe subito piegata con la semplice minaccia di
interrompere l'erogazione di quelle risorse da cui dipendono in
misura sempre maggiore.
Così concepita, la politica degli aiuti in linea generale non
ha alcun effetto positivo sui poveri del Sud, per il semplice
fatto che l'economia locale, che è l'unica a poterli sfamare,
non ha alcun bisogno delle autostrade, delle grandi dighe, delle
sementi ibride, dei concimi e dei pesticidi della "rivoluzione
verde". Questi prodotti interessano soltanto l'economia globale,
che si sviluppa a scapito di quella locale di questi paesi,
provocando danni permanenti all'ambiente, disgregando le
diverse comunità, saccheggiando le risorse una a una: acque,
foreste, terree manodopera.
La crisi del debito dell'inizio degli anni '80 aveva
completamente assorbito l'investimento privato nei paesi del Sud,
e tutto il nuovo denaro fornito dalle banche multinazionali
dello sviluppo serviva soprattutto a rimborsare gli interessi
sui prestiti che il paese debitore aveva contratto da
istituzioni private. Nel giro di qualche anno la situazione è
mutata. L'investimento privato in alcuni paesi del Sud chiamati
ormai "paesi emergenti" è aumentato progressivamente, fino a
raggiungere la cifra di 200 miliardi di dollari l'anno, dei
quali una metà viene destinata a investimenti a lungo termine e
l'altra a fondi di speculazione a breve termine.
Questo aumento massiccio si spiega in parte con lo scarto che
intercorre tra le immense somme di denaro a disposizione degli
Stati uniti e degli altri paesi industriali alla ricerca di una
collocazione, e la pressoché totale mancanza di opportunità di
investimento negli stati sviluppati; in parte per il fatto che
si sono create nel mondo intero condizioni altamente favorevoli
per le società multinazionali: l'abbondanza di una manodopera
non qualificata, ma anche di tecnici e quadri altamente
qualificati e a basso costo.
Come se non bastasse, queste società hanno accesso a tutti i
servizi finanziari e alle più moderne tecniche informatizzate di
produzione e di gestione. In più, l'Organizzazione mondiale del
commercio (Omc) obbliga ormai i paesi del Sud ad accettare ogni
investimento straniero; a trattare come "compagnia nazionale"
ogni impresa straniera che opera sul suo territorio, nel settore
agricolo, minierario, industriale e nei servizi; a eliminare i
dazi doganali e i contingenti di importazione su tutte le merci,
compresi i prodotti agricoli; ad abolire gli "ostacoli non
tariffari al commercio", cioè la legislazione sul lavoro, sulla
salute e sull'ambiente, che rischierebbero di far aumentare i
costi di produzione.
Nessun governo, nemmeno nel Nord, esercita più alcuna forma di
controllo sulle imprese multinazionali. Se una legge ostacola la
loro espansione, esse minacciano semplicemente di andarsene, e
lo possono fare seduta stante: sono libere di percorrere in
lungo e in largo il pianeta per cercare la manodopera meno cara,
l'ambiente meno protetto dalla legge, il regime fiscale meno
oneroso, i sussidi più generosi. Nessun bisogno di identificarsi
con una nazione o di mantenere un legame sentimentale (se non
patriottico) può intralciare i loro progetti. Esse sfuggono a
ogni forma di controllo.
Nella misura in cui poche ditte si impadroniscono del mercato
mondiale dei beni che producono, la concorrenza tra loro
risponde sempre meno ai loro interessi. La competizione riduce i
loro margini di guadagno, la cooperazione, invece, permette
loro di rinforzare la propria influenza sui governi e di
affrontare l'opposizione crescente di movimenti populisti,
nazionalisti o di altro tipo, che vorrebbero veder ridotti la
loro influenza e il loro potere. Sempre più, le imprese
praticano l'integrazione verticale, che permette loro di
controllare ogni tappa del funzionamento del loro settore,
dall'estrazione dei minerali, per esempio, alla costruzione
delle fabbriche, alla produzione di merci, allo stoccaggio, al
trasporto verso le filiali straniere, alla vendita all'ingrosso
e al dettaglio. In questo modo si assicurano che a stabilire i
prezzi siano, a ogni tappa, loro stesse e non il mercato come
invece vogliono far credere (16).
Le transazioni mondiali avvengono sempre più massicciamente tra
le multinazionali e le loro filiali. Non si tratta più di
autentico commercio, ma del prodotto di una pianificazione
privata centralizzata a scala planetaria. Secondo Paul Enkins,
economista britannico ed esperto di ecologia, le multinazionali
diventano "gigantesche zone di pianificazione burocratica,
nell'ambito di una presunta economia di mercato (17)". Secondo
lui, esiste una singolare analogia tra le ditte giganti e le
imprese di stato: "Entrambe utilizzano strutture gerarchizzate
per distribuire le risorse all'interno della loro organizzazione,
invece di rivolgersi al mercato".
Che cosa si può fare per impedire che il 50%, il 60% o l'80% del
commercio mondiale si risolva all'interno dei"confini di tali
organizzazioni"? La strada su cui ci stiamo immettendo potrebbe
condurci verso un'epoca di pianificazione centrale su scala
planetaria: il colonialismo globale delle imprese. Queste nuove
potenze coloniali rendono conto del loro operato soltanto ai
loro azionisti: non sono altro che macchine per accrescere il
loro profitto in maniera immediata (18). Finiranno per avere un
potere tale da essere in grado di costringere un governo, se ce
ne fosse bisogno, a difendere i loro interessi contro quelli
della popolazione che esso rappresenta.
Questo nuovo colonialismo delle imprese transnazionali rischia
di essere il più sfacciato e brutale che si sia mai visto.
Potrebbe tranquillamente impoverire ed emarginare le persone,
distruggere le culture, causare disastri ecologici, più di
quanto abbiano fatto il colonialismo di una volta o la politica
di sviluppo degli ultimi cinquant'anni. Quanto tempo reggerà?
Forse qualche anno, o qualche decennio, ma un'economia capace di
produrre miseria in questa misura non può sopravvivere a lungo.
note:
*Fondatore della rivista The Ecologist (Londra), autore, in
particolare, di Rapport sur la planète Terre, Stock, 1990.
torna al testo (1) François Partant, La fin du développement, François Maspéro,
Parigi, 1982.
torna al testo (2) Eric Jacoby, "Agrarian Unrest in South East Asia", New York,
1961, citato in George Beckford, Persistent Poverty, Zed Books,
Londra, 1983.
torna al testo (3) Randall Baker, "Protecting the environment against the
poors", The Ecologist, Londra, vol. 14, n&oord2, maggio-aprile 1984.
torna al testo (4) D. K. Fieldhouse, Economics and Empire, 1830 to 1914,
Macmillan, Londra, 1984.
torna al testo (5) Idem.
torna al testo (6) David Korten, The Failure of Bretton Woods, in Jerry Mander
e Edward Goldsmith The Case Against the Global Economy, Sierra
Club Books, San Francisco (sarà pubblicato nel settembre 1996).
torna al testo (7) D. K. Fieldhouse, op. cit.
torna al testo (8) François Partant, op. cit.
torna al testo (9) D. K. Fieldhouse, op. cit.
torna al testo (10) Kevin Danaher, Betraying the National Interest, Grove Press,
New York, 1988.
torna al testo (11) Marcus Colchester, "Slave and Enclave; Towards a Political
Ecology of Equatorial Africa", The Ecologist, vol. 23, n&oord5,
settembre-ottobre 1993.
torna al testo (12) Walden Bello, Dark Victory, Pluto Press, Londra 1994.
torna al testo (13) D. K. Fieldhouse, op. cit.
torna al testo (14) Harry Magdoff, Imperialism: From the colonial Age to the
Present, Monthly Review Press, New York, 1978.
torna al testo (15) Cheryl Payer, Lent and Lost: Foreign Credit and Third World
Devolopment, Zed Books, Londra, 1991.
torna al testo (16) Citato da John Hultgren, "International Political Economy
and Sustainability", contributo non pubblicato, Oberlin College,
maggio 1995.
torna al testo (17) Paul Ekins, "Trade and Reliance", The Ecologist, vol. 19,
n&oord5, settembre-ottobre 1989.
torna al testo (18) Jerry Mander, "The Corporations as a Machine" in Jerry
Mander e Edward Goldsmith, op. cit.
(Traduzione di C.M.)
Articolo tratto da Le Monde Diplomatique di Aprile-1996, inserto mensile de il manifesto