
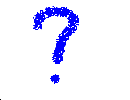
 |
|
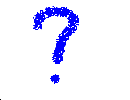 |
Premessa
Il documento prodotto dai 18 saggi della commissione ministeriale può
essere legittimamente considerata come erede della famigerata “legge Ruberti”
del 1989, contro la quale in tutta Italia si mobilitò la Pantera,
l’ultimo momento di protagonismo studentesco negli anni ’90 crediamo che
questo documento sia figlio legittimo di quella legge perché ne
condivide l’impianto e le finalità. Se quella, introducendo l’autonomia
finanziaria degli atenei, mirava al progressivo disimpegno pubblico in
tema di spesa per l’Università (la cui logica conseguenza furono
gli aumenti a raffica delle tasse d’iscrizione tra il 1992 e il 1994),
questo intende introdurre il principio dell’autonomia didattica ovverosia
lo sganciamento dei singoli atenei da un piano di studi nazionale. Questo
principio di per se non negativo, oggi, ha esclusivamente il significato
di consegnare, mani e piedi legati, la formazione universitaria ai bacini
di impresa locali, spostando il confronto tra sistema delle imprese e sistema
della formazione nel luogo in cui la prima è più forte e
la seconda più debole.
Anche nella metodologia questo documento si propone di seguire lo stesso
percorso della Ruberti. Una legge allora, un documento oggi, elaborato
esclusivamente dai baroni universitari ben seduti sui loro scranni feudali
e da funzionari ministeriali esaltati dalla loro missione tecnocratica
di “modernizzazione“ dell’Università. Nessun coinvolgimento nell’elaborazione,
naturalmente, da chi l’Università la fa vivere realmente: studenti,
ricercatori, impiegati amministrativi... ancora una volta gli unici legittimati
a parlare dell’Università e a progettarci sopra sono coloro che
da sempre la governano.
Riflessioni
In primo luogo ad un’attenta analisi, il documento del gruppo di lavoro
ministeriale sull’attivazione dell’autonomia universitaria, ci sembra rispondere
alla medesima logica che ha presieduta alla riforma dei servizi pubblici
e del Walfare State. In uno slogan potremmo definirla una logica di contemporanea
centralizzazione e autonomia.
Nella presentazione infatti gli esimi professori che compongono il
gruppo di lavoro affermano che “... non è possibile delineare un
quadro di riforma dall’alto, ma si devono delineare i criteri minimi generali
ai quali devono attenersi gli atenei, liberi per altro di estendere la
propria azione al di là di questi confini, e com’è stato
detto più volte, di fare tutto ciò che non è espressamente
regolato”.
Cosa significa tutto ciò? Che vengono demandati al centro (cioè
al Ministero) la definizione del quadro complessivo all’interno del quale
gli enti universitari autonomi devono poi muoversi. Apparentemente si tratterebbe
di un’intenzione positiva, da momento che da un lato verrebbero mantenute
garanzie comuni estese all’intero territorio nazionale, dall’altro verrebbero
permesse alle singole Università sperimentazioni locali e movimenti
autonomi. Dietro a questa cortina fumogena si nascondono, in realtà,
ben altre intenzioni: con questo doppio movimento lo Stato continua nell’operazione
di sgravio dal bilancio delle spese universitarie. Vengono stabiliti dei
requisiti minimi, sostenuti dal bilancio ministeriale, relegando i restanti
costi all’autonoma iniziativa delle singole Università. Si tratta
quindi di una forma surrettizia di introduzione del vincolo di bilancio:
a livello centrale viene determinato il costo complessivo che il bilancio
pubblico intende sobbarcarsi. Costo complessivo che verrebbe a coincidere
con il finanziamento per l’appunto dei requisiti minimi (che attendiamo
con ansia ci vengano indicati).
In questo modo è il Ministero stesso a determinare il livello
di spesa pubblica per l’Università; quindi, con buona pace di Tranfaglia
e soci, quest’ultima verrebbe decisa non dall’alto, ma dall’Altissimo:
dove con questa espressione non intendiamo riferirci a nient’altro
che all’unico Dio che determina le nostre esistenze: quello della riduzione
della spesa pubblica per “esigenze di bilancio”. Viene quindi ribaltato
il criterio che, almeno teoricamente, presiedeva alla determinazione della
spesa pubblica (in questo caso per l’istruzione universitaria): invece
di determinare la spesa a partire dalle esigenze di sapere e formazione
della società, sono queste ultime a venir determinate dalle esigenze
del bilancio pubblico, determinate a priori in forma politica, ancorché
spacciata per “esigenza tecnica”. Nel contempo le singole Università
sono lasciate “libere” di cercarsi altrove i fondi con i quali finanziare
tutto ciò che esubera dai requisiti minimi (cioè, immaginiamo,
l’80-85% del finanziamento universitario).
Ci troviamo quindi di fronte alla trasformazione di Rettori e Presidi
da figure di gestori di un’attività didattica e organizzatori dell’attività
di formazione e ricerca in manager- accattoni, valorizzati in quanto capaci
di reperire i fondi che permettano ai loro atenei e alle loro facoltà
di non cadere a pezzi. Dove verranno trovati questi fondi è facile
capirlo: nonostante un’Università così concepita sia quanto
si possa pensare di più vicino agli interessi imprenditoriali (sul
punto torneremo più avanti), è del tutto chiaro come al “benefico
e salvifico” privato non passi neanche per la testa di finanziare
l’Università, se non con ridicole donazioni che le grandi imprese
(FIAT in testa) concedono ogni tanto come regalie a scopo pubblicitario
tramite le loro fondazioni. D’altronde anche nel tempo antico imperatori,
papi e feudatari vari concedevano una tantum piccole somme di denaro allo
scopo di edificare pubblici edifici da dedicare alla propria memoria. Il
sistema delle imprese non ha infatti alcuna intenzione di finanziare i
costi di formazione della propria futura forza-lavoro.
Per più di cento anni li ha considerati come costi che l’intera
collettività doveva sobbarcarsi tramite la fiscalità generale,
secondo l’equazione per la quale il denaro speso per lo sviluppo e la competitività
imprenditoriale era denaro speso per il bene della società, e quindi
avrebbe dovuto essere la stessa società a sopportarne i costi. Con
questa riforma siamo ad un’ulteriore mistificazione: il denaro speso
per la formazione della forza lavoro è denaro che serve alla valorizzazione
della stessa forza lavoro in formazione, quindi deve essere quest’ultima
a sobbarcarsene il costo. D’altronde viviamo in un tempo che ha fatto dell’autoimprenditorialità
e della valorizzazione individuale il proprio fulcro ideologico e quindi
non è strano che in questo contesto i costi sostenuti per riuscire
ad entrare nel mercato del lavoro siano visti come un investimento individuale.
In altre parole, utilizzando un paragone merceologico, sarebbe come
se le imprese alimentari chiedessero ai pomodori di sobbarcarsi il costo
per diventare pelati, ossia utilizzabili per il profitto delle imprese
stesse.
Con questa operazione le imprese ottengono due obiettivi: da un lato
limitano la spesa pubblica per l’istruzione liberando ulteriori risorse
da destinare a loro sostegno nelle più varie forme (e abbassando
la quota di tassazione nei loro confronti), dall’altro fanno ricadere le
loro esigenze di personale specializzato direttamente su chi spera di diventarlo.
Per di più compiono questa operazione con un plauso generalizzato
ai “ritrovati valori di competitività e imprenditorialità
individuali”.
Saremo quindi noi studenti a dover pagare i costi della festosa autonomia
universitaria tramite l’aumento dei contributi, piuttosto che con le mille
tasse e balzelli che la fantasia dei nostri manager-accattoni saprà
inventarsi. Pomodori, pagheremo il processo produttivo per essere inscatolati,
magari con una lussuosa etichetta.
In secondo luogo, conseguentemente a questo processo, le Università
verranno messe sul mercato, ossia verrà attuata quella che i professorini
nel loro documento chiamano “diversificazione competitiva” tra i vari atenei.
In parole povere ogni Università, ogni Facoltà, ogni corso
di Laurea dovrà inventarsi le forme migliori per catturare il maggior
numero di studenti-clienti che con i loro soldini le permettono di svilupparsi
nel modo migliore. Ovviamente, oltre ad una serie di “insegne luminose
che attirano gli allocchi” come i corsi del DAMS a Torino, il livello decisivo
per questa competizione non potrà che giocarsi su due livelli: le
possibilità di successo dei futuri laureati sul mercato del lavoro,
e quindi il grado di integrazione delle Università con il bacino
delle imprese locali, da un lato e i servizi offerti dall’altro. E’ del
tutto evidente che in questi ultimi saranno tanto maggiori quanto più
alte e più estese saranno le contribuzioni studentesche. Si introduce
quindi con questo criterio un’ulteriore diversificazione tra Università
a seconda della loro collocazione geografica: le contribuzioni saranno
ovviamente diverse tra zone dove il reddito medio permette una determinata
spesa alla popolazione universitaria e in quella dove non la permette.
A meno che qualcuno creda che il bacino di utenza di Cosenza (46,3% di
disoccupazione giovanile) sia lo stesso di quello di Padova.
Complementare alla messa sul mercato delle Università è
la trasformazione dello studente da utente a cliente che ottiene, pagando,
il diritto di accedere ad un determinato servizio. I clienti, a seconda
delle proprie esigenze, potranno scegliere di essere studenti a tempo pieno
o a tempo parziale grazie alla “lifelong learning”, perversa formula di
studio dilazionato attraverso la quale si stravolge il principio della
formazione permanente, filo rosso che collega le lotte studentesche degli
anni settanta a quelle odierne. Nasce così il sospetto che le esigenze
a cui sembra si voglia venir incontro non siano tanto quelle di un libero
accesso al sapere quanto quelle di un libero accesso (a pagamento) alle
aziende nella forma di corsi di aggiornamento o di formazione dei propri
dipendenti. In altre parole l’Università si prende carico di un
ulteriore bisogno delle imprese, quello di aggiornare e formare periodicamente
i propri lavoratori, scaricandolo sulle spalle dei lavoratori stessi che
non solo non avranno più diritto alla formazione pagata, ma dovranno
addirittura pagarsela da soli, in quanto travestita da corso universitario.
Qui siamo a quello che la “banda del Buco” del gruppo di lavoro ministeriale
chiama la contrattualità del rapporto studente-ateneo. In parole
povere verrebbe cancellata l’universalità dell’Università
come servizio uguale per tutti e sottoposto alla razionalità burocratica
del servizio pubblico, per sostituirla con la logica privatistica del “cliente”
che acquista un determinato percorso formativo, pagandolo, e obbligandosi
nei confronti dell’Università a seguirlo secondo uno schema prefissato.
Cosa succederà a chi non saprà o non potrà rispettare
i termini del suo contratto ?
Una cura particolare viene riservata dagli estensori del documento
alla figura, definita “anomala”, del fuori corso. Ovverosia, per lo più,
dello studente lavoratore.
Nei progetti di questi signori, lo studente-lavoratore dovrebbe venir
eliminato dal corso di studi più “serio”, quello che permetterà
di accedere ai lavori più pagati e garantiti, dirigendoli verso
corsi di studio e diplomi di laurea “inferiori”, con sbocchi meno garantiti.
Insomma un ulteriore passo nel senso della gerarchizzazione dell’Università
e dei suoi corsi di studi, e di una selezione che predetermini il posto
nella società che ognuno occuperà.
L’esser considerati clienti diminuisce le possibilità, già
oggi oltremodo scarse, di poter intervenire sulle politiche universitarie
e di poter controllare il funzionamento dell’Università stessa:
la figura dello studente-cliente incarna pienamente l’idea di “kalos kai
agazos” cioè di un corpo studentesco d’élite docile ed arrendevole
e soprattutto fiero di esser riuscito là dove un alto numero di
“studenti-Tersite” ha fallito.
E’ del tutto ovvio che ci troviamo di fronte ad una mistificazione, chi acquista una casa è qualcuno che soddisfa un bisogno elementare purtroppo pagando; chi acquista un percorso formativo è qualcuno che si trova a dover pagare per ottenere il discutibile privilegio di essere in futuro messo in produzione da qualche impresa. Privilegio, per di più, nemmeno garantito. Lo studente si troverà così nella spiacevole posizione di chi, per soddisfare i bisogni della propria azienda, si trova a pagare un corso di inglese o tedesco, senza nemmeno la certezza di poter conservare il posto, fluent english, o meno.
In terzo luogo questo testo introduce sotto le voci “pluralità
delle offerte”, “flessibilità curriculare”, “mobilità delle
risorse umane” e “sistema dei crediti educativi”, un criterio di completa
adesione delle Università a bisogni imprenditoriali del proprio
bacino geografico di appartenenza.
Dietro ai paroloni colti il simpatico gruppetto di fregadolci, introduce
infatti i criteri base per diversificare l’offerta di corsi universitari
a seconda delle esigenze imprenditoriali, puntando alla creazione di camaleontiche
figure che possano adattarsi alle necessità delle imprese.
Questo processo avviene in due sensi: da un lato gerarchizzando l’istruzione
universitaria preparando così sia figure operaie specializzate,
sia tecnici, abbattendo così i costi di formazione interna delle
imprese; dall’altra diversificando i corsi di laurea in forme sempre più
specialistiche a seconda delle esigenze contingenti dei bacini di impresa.
Un ottimo esempio di quest’ultima tendenza è il già attivato
(dal 1994) corso di laurea per il design del legno che l’Università
di Como ha aperto a Vimercate, in uno dei distretti padani del legno. E
se per caso la produzione per la quale il corso specifico è stato
pensato non tirasse più? Niente paura i nostri eroi hanno pensato
alla “possibilità di avviare - e chiudere - corsi di studio di vario
tipo” con l’ovvia conseguenza dell’”eliminazione della rigida corrispondenza
tra docente e cattedra/materia”, ossia, per meglio dire, con la creazione
di una fascia di docenti con contratto a termine, ovviamente precarizzati,
ricattabili e, in ultima analisi, asserviti alla casta baronale dei docenti
che, per diritto divino, manterrebbero l’esacrata corrispondenza tra cattedra
e professori giustificata dalla non chiudibilità dei corsi universitari
“classici”.
La flessibilità curriculare non apre le porte ad una più
ampia scelta di corsi (e quale? Visto che, in rispetto dei criteri introdotti
dalla l.127/97, solo il 10% del proprio piano di studi può esser
scelto liberamente dallo studente?), quanto piuttosto permetterà
ai vari consigli di facoltà di introdurre nuove e temporanee discipline
che suscitino l’interesse del mondo imprenditoriale del proprio bacino
d’utenza, precarizzando così, tra l’altro, una fascia di docenti.
Il sistema dei crediti, determinati per ogni insegnamento in base alla
struttura didattica, trasforma gli studenti in novelli “cercatori d’oro”
che riscuoteranno il loro premio con il superamento della prova d’esame
e, dopo varie peripezie, la caccia al tesoro giungerà all’agognato
epilogo: lo studente-eroe raggiunto un certo numero di crediti potrà
finalmente essere ammesso all’esame finale del suo corso di laurea.
L’introduzione di un primo anno orientativo e l’aumento dei diplomi
universitari (trasformati in piccoli traguardi intermedi), diretta conseguenza
del sistema “creditizio”, favorirà una selezione tipo corsa ad ostacoli,
creando una serie di titoli di studio dal valore alquanto dubbio: la specificità,
unica garanzia del diploma universitario, poco si concilia con l’infernale
idea della mobilità lavorativa, vero dogma dell’economia post-fordista,
in cui il “factotumismo” è elemento essenziale e necessario. Da
questo punto di vista la controriforma-Tranfaglia e soci segna un radicale
mutamento dello status studentesco: l’ormai famoso pomodoro non solo paga
il suo inscatolamento, ma secondo i dettami della produzione post-fordista
sceglie, in modo del tutto individuale e solitario, la confezione.
Dietro questa trasformazione è leggibile un ansia di adeguare
l’Università italiana alla realtà di imprese lanciate nella
competizione globale. Usando (ed “abusando”) di uno slogan divenuto ormai
luogo comune, potremmo definirla come la prima riforma post-fordista dell’istruzione
universitaria. Se la sedicente Università di massa così come
l’abbiamo conosciuta doveva soprattutto servire a produrre quadri intermedi
di diverso tipo (tecnico-scientifici, impiegatizzi, medico-ospedalieri....)
allo scopo di immettere sempre olio nuovo per lubrificare il motore di
imprese di grandi dimensioni che, mantenendo tutte le funzioni produttive,
distributive, e organizzative all’interno dell’impresa, avevano fame di
figure di coordinamento e di gestione, ora l’impresa leggera del post-fordismo
ha necessità sia di poche figure estremamente specializzate, da
impiegare nei settori strategici della produzione, sia del costituirsi
di un bacino di lavoratori autonomi e precari utilizzabili temporaneamente,
dequalificati per ruolo e reddito, ma dotati di saperi e capacità
e disponibili alla massima flessibilità di impiego.
Non diversamente il settore pubblico nutrito per anni da impiegati,
professori, etc provenienti dall’Università, ha subito un deciso
dimagrimento tramite la pratica dell’appalto esterno di funzioni specifiche
e la riduzione generalizzata del personale. Oggi quindi il settore pubblico
ha necessità di meno personale, che seleziona sempre meno tramite
concorsi, e sempre più tramite scuole di specializzazione post-universitarie,
parauniversitarie etc. Esemplare da questo punto di vista la vicenda delle
scuole di specializzazione per l’insegnamento: pochissimi posti, frequenza
obbligatoria, pagamento dei corsi a carico degli studenti.
Di certo un forte decentramento porta a uno sgretolamento, di quella
che può essere, in
sede contrattuale ,il potere del corpo studentesco nel trattare temi
universali. Lo studente, infatti, si troverà ad affrontare problemi
specifici del proprio ateneo, quali ad esempio l’ordinamento didattico
o, nel caso dell’Università di Palermo la contestazione delle scuole
di specializzazione affrontata in maniera formale anziché sostanziale
.Questa situazione ci sembra pericolosa dal momento in cui si giunge, dopo
settant’anni, a una riforma radicale del sistema scolastico e universitario
italiano. Rivendichiamo, al di là delle imposizioni dall’alto (lo
statuto del bravo studente e i tavoli contrattuali proposti dal ministro
Berlinguer) e delle flatulenze di partito nel mondo studentesco (C.L.,
F.U.A.N., U.D.U...),il potere di ogni singolo studente di decidere quale
sia la propria Università.
Inoltre non possiamo accettare la totale cancellazione di vent’anni
di lotte per una Università accessibile a tutti, condotte anche
da chi ora, comodo sul proprio trono baronale, cerca di trasformare noi
in tanti bravi Garrone e l’Università in un feudo dal quale controllare
dall’alto i propri vassalli.
In estrema sintesi questa riforma partorita dai “magnifici 18” coordinati
dal prode Martinotti, è la prima riforma universitaria completamente
“ made in CONFINDUSTRIA”. Tanto per adeguare il noto adagio, ci vogliono
professori universitari di sinistra (o di centro-sinistra) per fare una
riforma universitaria di destra. Non a caso il prof. Tranfaglia, noto esponente
della sinistra universitaria torinese, figura in primo piano in questa
schiera di cancellatori del diritto allo studio universitario.
D’altronde vista l’appartenenza di questo eroe del nostro tempo a quella
sinistra cinica e nihilista, senza alcun orizzonte che non sia l’interesse
confindustriale e la gestione spregiudicata della macchina pubblica, che
spadroneggia oggi nel nostro paese, non vediamo come sarebbe potuta andare
diversamente.
A futura memoria, professore.
In conclusione
L’insieme di questo progetto possiede tutti i crismi della negatività
assoluta. Non è possibile pensare di separare il grano dal miglio
nelle parole dei 18 bonzi.
Lanciarsi in sterili battaglie per emendare questo testo, migliorarlo
e mutarlo, è quanto di più inutile si possa immaginare. Questo
progetto e soprattutto la logica che vi presiede va rifiutata in blocco.
Un protagonismo studentesco, una decisa capacità di trasformare
l’Università da parte di chi la vive tutti i giorni, può
essere pensata solo a partire dal rigetto di quest’ultimo.
Dobbiamo rilanciare la battaglia per un’Università libera, aperta,
gratuita e gestita direttamente da chi (studenti, corpo docenti, impiegati
amministrativi) realmente la struttura.
Siamo pomodori, non finiremo in scatola.