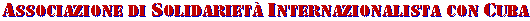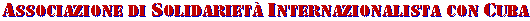Fortune e sfortune
delle organizzazioni mondiali
Le Nazioni unite e gli interessi americani
L'Onu è obsoleta? Mentre si riunisce la sua cinquantesima
Assemblea generale, l'organizzazione deve fare un bilancio delle
grandi rivoluzioni che hanno scosso il pianeta in mezzo secolo:
sconvolgimenti demografici e scientifici, decolonizzazione,
estinzione del comunismo, vittoria del capitalismo. Lo scontro
est-ovest è ormai cosa del passato, ma le sfide della miseria,
delle ineguaglianze, dell'usura ecologica, permangono. Certo,
l'Onu deve rinnovarsi, ma né essa né le organizzazioni che ne
dipendono (si veda l'articolo a pag 11) devono essere messe al
servizio degli interessi degli Stati uniti.
di gilbert achcar*
L'Organizzazione delle Nazioni unite, contrariamente alle
istituzioni di Bretton Woods, nelle quali la preponderanza
statunitense è assicurata dalla ripartizione dei voti secondo le
quote finanziarie versate, era stata concepita in modo un po'
"idealista". Il "principio di eguaglianza sovrana di tutti i
membri" inscritto nella Carta, accordava a ogni stato un solo
voto e quindi un eguale peso nelle votazioni all'Assemblea
generale. Anche se questo principio era controbilanciato dal
carattere non obbligatorio delle risoluzioni dell'Assemblea
(delle semplici "raccomandazioni" sulle questioni più
importanti). D'altronde, le regole di funzionamento del
Consiglio di sicurezza cinque membri permanenti con diritto di
veto impedivano il ricorso al capitolo VII della Carta, cioè
l'adozione di misure coercitive, ivi compreso l'impiego della
forza armata, contro il volere di una delle potenze vincitrici
nel 1945.
Secondo Washington, l'Onu avrebbe dovuto essere uno strumento di
consolidamento e di mantenimento della pace in un nuovo ordine
nato dalla guerra e ampiamente dominato dagli Stati uniti, forti
di circa la metà del Pil mondiale e sola potenza nucleare nel
1945. All'Assemblea generale, Washington dettava legge
attraverso il voto maggioritario dei numerosi stati che dovevano
loro qualcosa (nel 45, su 51 membri dell'organizzazione solo
dieci appartenevano all'Asia o all'Africa, tra cui l'Unione
sudafricana). Invece, il Consiglio di sicurezza era stato
concepito come il luogo del consenso tra le grandi potenze. Di
conseguenza, è stato assai spesso paralizzato da veti potenziali
o effettivi, nel corso dei 45 anni che sono trascorsi dalla
fondazione dell'Onu alla guerra del Golfo.
Mosca ha fatto ricorso in modo intensivo, quasi sistematico, al
diritto di veto nel corso dei primi anni della guerra fredda: 77
volte dal 1945 al 1955. Fu solo grazie al boicottaggio
temporaneo del Consiglio di sicurezza da parte dell'Urss, per
protestare contro la concessione del seggio alla Cina di Formosa,
che l'amministrazione Truman, nel giugno del 1950, riuscì a far
intervenire in Corea le sue truppe e quelle dei suoi alleati
sotto l'egida delle Nazioni unite. Ma quando l'Urss tornò sui
suoi passi, il segretario di stato statunitense, Dean Acheson,
ebbe l'idea di aggirare il veto sovietico rendendo possibile il
ricorso all'Assemblea in caso di blocco del Consiglio
(risoluzione "Unione per la pace" del 3 novembre 1950). A tal
punto gli Stati uniti erano sicuri della loro capacità di
controllo sull'Assemblea.
Solo nel 1970 Washington ritenne necessario utilizzare il
proprio diritto di veto (nei confronti dell'Africa australe). E
nel corso degli anni successivi, gli Stati uniti utilizzeranno
il proprio potere di blocco più frequentemente dell'Urss. Nel
frattempo, in effetti, la composizione dell'Assemblea era
radicalmente cambiata, provocando una modificazione dei rapporti
di forza all'interno dell'organizzazione, ivi compreso il
Consiglio di sicurezza: il numero dei membri non permanenti era
stato portato da sei a dieci nel 1965. L'arrivo massiccio di
stati afro-asiatici all'Onu a partire dal 1960, sull'onda delle
decolonizzazioni, parallelamente alla crescita del "neutralismo",
dovevano progressivamente creare una maggioranza che,
formalmente "non allineata", era in realtà ostile ai disegni
egemonici degli Stati uniti, ritenuti la principale potenza
"neocoloniale".
Il rovesciamento della situazione raggiunse l'apice nel corso
degli anni '70, in particolare quando l'Assemblea, a gran danno
di Washington, definì il sionismo "una forma di razzismo e di
discriminazione razziale", dopo essersi pronunciata a favore di
"un nuovo ordine economico internazionale". La reazione degli
Stati uniti, su questo come su molti altri terreni, fu
estremamente vivace sotto la presidenza di Ronald Reagan.
Washington, denunciando la "tirannide della maggioranza", chiese
che il peso del voto dei membri dell'organizzazione relativo al
bilancio fosse misurato sulla base dei contributi versati per il
bilancio medesimo (1). L'amministrazione statunitense decise di
ridurre il proprio apporto dal 25% del bilancio al 20%, fino a
quando la propria richiesta non fosse stata accettata. Inoltre,
impose ritardi e trattenute nei pagamenti, provocando una grave
crisi finanziaria.
La seconda svolta
Parallelamente, il divorzio politico tra Washington e
l'organizzazione si accentuava, in particolare con la condanna
dell'Onu al blocco dei porti del Nicaragua nel 1984, e in
seguito al bombardamento statunitense della Libia nel 1986.
Ma gli Stati uniti, benché l'Assemblea abbia riconosciuto loro
nel 1986 un diritto di veto de facto sull'utilizzazione del
bilancio, proseguivano nel braccio di ferro finanziario, dopo
aver fatto un importante versamento di arretrati nel 1987. La
guerriglia continuava nel 1988, con il rifiuto di accogliere
Yasser Arafat a New York, che obbligò l'Assemblea a spostarsi a
Ginevra per ascoltare il leader palestinese. Ebbe una fiammata
all'inizio della presidenza di George Bush: l'Assemblea condannò
l'intervento delle truppe Usa a Panama nel dicembre del 1989.
Sotto la spinta della diplomazia sovietica diretta da Gorbaciov,
i segni di un cambiamento si moltiplicavano. Il presidente
Reagan, alla fine del suo secondo mandato, aveva già preso
coscienza della possibilità di riattivare il ruolo dell'Onu in
direzione conforme agli orientamenti statunitensi. Ma il
Congresso, reticente a seguirlo su questa strada, gli rifiutò i
mezzi per pagare gli arretrati che gli Usa dovevano
all'organizzazione. E tuttavia il cambiamento continuò a seguire
il suo corso, in particolare con gli interventi dell'Onu nel
regolamento pacifico dei conflitti che opponevano, per procura,
gli Stati uniti all'Urss sul continente africano. Le due
superpotenze accettarono l'intervento di osservatori delle
Nazioni unite con fini di supervisione: Mosca in Afghanistan, a
partire dal 1988, per il ritiro delle proprie truppe, e
Washington in America centrale, dal 1989, per la smobilitazione
dei "contras" in Nicaragua.
Due fattori accelerarono questa seconda svolta, molto più
drastica della prima, nelle relazioni tra Washington e l'Onu. In
primo luogo, sicuramente, l'agonia dell'Urss, che ha comportato
un cambiamento radicale nei rapporti tra i due supergrandi. Il
"multilateralismo", che per Washington non ha mai significato
altro che la formazione di coalizioni militari sotto l'egemonia
statunitense, di preferenza con l'avallo dell'Onu, diventava di
nuovo una prospettiva plausibile tanto più attraente per il
fatto che l'interventismo unilaterale degli Stati uniti aveva
ricevuto un forte colpo dalla guerra del Vietnam.
L'altro fattore, congiunturale, sarà la crisi del Golfo,
conseguenza dell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq il 2
agosto 1990. Costituirà in un certo senso il banco di prova
della fine della guerra fredda e del nuovo "multilateralismo":
per la prima volta, le grandi potenze condannavano all'unanimità
uno dei grandi stati del terzo mondo, arrivando persino a
decretare contro di esso un blocco navale e ad autorizzare la
cacciata delle sue truppe "con tutti i mezzi necessari". Per la
prima volta dal 1950, quando l'Urss aveva boicottato il
Consiglio di sicurezza per solidarietà con la Cina continentale,
l'articolo 42 della Carta che prevede il ricorso alla forza
militare era di nuovo invocato, ma questa volta con l'avallo del
Cremlino e l'astensione consenziente di Pechino.
George Bush comprese molto in fretta i vantaggi che avrebbe
potuto trarre dalla compiacenza manifestata da Mosca nei suoi
confronti, fin dall'inizio della crisi. Il "multilateralismo"
era così destinato a diventare una pietra miliare dell'impresa
di marketing politico realizzata dall'amministrazione Bush per
"vendere" la guerra che stava preparando all'opinione pubblica
statunitense e al Congresso.
In quel "momento unipolare" (2), la copertura dell'Onu era
paradossalmente più utile alla Casa Bianca per fini di politica
interna che per i possibili benefici militari derivanti dalla
partecipazione degli alleati. Il principale problema
dell'interventismo era quello della legittimazione agli occhi
degli statunitensi stessi: a questo riguardo, il consenso
espresso dall'Onu, tanto più prezioso perché inedito, dava un
apporto decisivo (3).
Altro interesse, e non certo minore, della copertura dell'Onu:
legittimare il mezzo scelto da Washington per evitare l'altro
grande ostacolo all'interventismo statunitense: il problema del
finanziamento di uno sforzo militare massiccio in un periodo di
deficit di bilancio colossale e di indebitamento netto degli
Stati uniti. La soluzione fu la partecipazione alle spese degli
alleati più ricchi: monarchie petrolifere del Golfo, Giappone,
Germania ecc. Il segretario di stato, James Baker, si distinse
talmente in questo esercizio, da meritare il soprannome di
"madre di tutti i raccoglitori di fondi" (mother of all
fundraisers) da parte di due esponenti eminenti del think tank
della diplomazia statunitense (4). In effetti, la "colletta" fu
consistente: 53 miliardi di dollari, ampiamente sufficienti per
coprire le spese del Pentagono, se non addirittura permettergli
qualche guadagno.
L'intervento in Somalia deciso da Bush nel dicembre 1992 in
modo inabituale, giusto prima di cedere il posto al suo
successore, eletto contro di lui si inscriveva in una logica di
conservazione di ciò che appariva come la principale conquista
di questa era in via di conclusione: il rinnovamento della
capacità morale degli Stati uniti a intervenire militarmente,
agendo sotto la bandiera dell'Onu. Il presidente, lasciando a
Clinton il compito di gestire un'operazione già in corso,
esorcizzava in un certo senso il passato di oppositore alla
guerra del suo successore (5). Il tema scelto sembrava prestarsi
a meraviglia, dal punto di vista del consenso internazionale e
della legittimità, agli occhi dell'opinione pubblica
statunitense (6). Il risultato finale è stato però tutto il
contrario del previsto.
Cattiva gestione dell'intervento o errata definizione dei
compiti? Come sia, nel marzo 1994, quando le truppe statunitensi
lasciavano la Somalia, la patologia del Pentagono si era
arricchita di una "sindrome somala", andata ad aggiungersi alla
"sindrome di Beirut" e alla "sindrome vietnamita", che rimane
ancora molto forte (7). Sindromi che hanno inibito qualsiasi
tentativo statunitense di inviare delle truppe in Bosnia,
mettendo così in rilievo il carattere eccezionale del conflitto
del Golfo, dove la configurazione del terreno si era prestata,
come da nessun'altra parte, alla guerra elettronica.
L'intervento statunitense ad Haiti nel settembre del 1994, anche
se vicino al modello creato nel 1990 coalizione dominata dagli
Stati uniti sotto copertura Onu evidenziava più i problemi
legati alla riproduzione di questo modello che la sua efficacia.
Sapendo che si trattava di un paese molto vicino alle coste
statunitensi, la cui situazione ha delle ricadute dirette sulla
vicina superpotenza, non resta che stupirsi per l'ampiezza della
resistenza che l'amministrazione Clinton ha dovuto fronteggiare
al Congresso e nell'opinione pubblica prima di imboccare questa
strada. Una resistenza che lo ha spinto a negoziare un
compromesso con la giunta prima dell'intervento.
In realtà, il vento dell'"isolazionismo" sembra vincere negli
Stati uniti da almeno due anni a questa parte. L'entusiasmo
"internazionalista" suscitato dalla guerra del Golfo è stato
altrettanto effimero della promessa del "nuovo ordine mondiale"
che l'aveva accompagnata. La fine della guerra fredda ha
piuttosto nutrito l'idea, molto diffusa tra gli statunitensi,
che il loro paese, dopo aver portato il principale fardello
della lotta anti-comunista, adesso deve godere di un riposo ben
meritato. Di conseguenza, la nuova luna di miele tra Washington
e l'Onu, inaugurata da Bush, è stata troppo breve per cancellare
l'eredità di due decenni di litigioso divorzio. E, come nel
corso degli anni precedenti, le difficoltà si traducono in
problemi finanziari. Washington si nasconde dietro la bandiera
dell'Onu, quando questo le fa comodo, e lo fa tanto più
volentieri quando l'intervento delle sue truppe è finanziato
dagli altri con il pretesto del "multilateralismo". In questo
tipo di interventi, inquadrati dal capitolo VII della Carta, le
truppe statunitensi agiscono sotto propri comandi, senza doversi
piegare a utilizzare simboli come il casco blu.
Ma quando gli Stati uniti devono contribuire al finanziamento di
unità a cui non partecipano o di cui non controllano il comando
come è il caso delle forze di "mantenimento della pace" che
agiscono sotto comando Onu continuano a frapporre difficoltà
per i finanziamenti (8). Risultato: gli arretrati dovuti dagli
Stati uniti all'organizzazione internazionale oltrepassavano già
1,5 miliardi di dollari al 31 agosto 1994, cioè alla fine del
precedente esercizio finanziario, due terzi dei quali dovuti per
operazioni di "mantenimento della pace".
Il nuovo "unilateralismo"
Il Congresso "introvabile" eletto nel 1994 non può che aggravare
lo stato delle relazioni tra l'Onu e il paese che ne ospita la
sede, tanto più che Clinton è poco incline a condurre battaglie
su questo terreno. Inoltre, da allora, la volontà statunitense
di togliere l'embargo sulle armi alla Bosnia, fortemente
maggioritaria al Congresso e, per un certo periodo, condivisa
dal governo, si è scontrata con il rifiuto di altre potenze del
Consiglio di sicurezza. Washington è stata costretta persino a
ricorrere al veto, il 17 maggio scorso, su una questione che
riguardava Israele: era la prima volta dal 1990.
Certamente, tra la retorica "isolazionista" e spesso demagogica
dei leader della destra repubblicana trionfante, e gli interessi
"pesanti" di un paese sempre più sensibile a ciò che succede nel
resto del mondo, c'è una contraddizione che non manca di
raffreddare, o anche di correggere, le passioni dei primi. A
riprova di ciò, per esempio, il National Security Revitalization
Act, adottato dal nuovo Congresso, e attraverso il quale
quest'ultimo cercava di imporre al presidente il proprio avallo
prima di porre truppe statunitensi sotto comando Onu, è stato in
realtà sensibilmente attenuato.
Brent Scowcroft e Arnold Kanter, due membri eminenti
dell'amministrazione "internazionalista" di Bush, hanno
sottolineato in un articolo l'originalità di ciò che chiamano
"il nuovo unilateralismo". Contrariamente all'isolazionismo
tradizionale, questo non nega l'interdipendenza fra gli Usa e il
resto del mondo, ma riflette "il fatto di non essere disposto ad
assumersi il pesante compito di esercitare la leadership
internazionale, e di essere incline non solo a condividerne il
peso con altri, ma addirittura a sbarazzarsene. Per semplificare,
il nuovo unilateralismo sottintende un approccio in politica
estera in base al quale gli Stati uniti si occuperanno del mondo
fino a quando dovranno farlo, ma lo faranno soltanto a modo loro,
secondo un proprio calendario e a determinate condizioni" (9).
I due autori criticano la miopia del "nuovo unilateralismo" che
scoprono negli atti dell'amministrazione Clinton, in particolare
nella minaccia di non tener conto delle risoluzioni dell'Onu per
quanto riguarda gli embarghi che interessano l'Iraq e la Bosnia.
Giudicano questo atteggiamento dannoso agli interessi degli
Stati uniti, in particolare per ciò che riguarda
l'organizzazione internazionale: "Quando Washington seleziona e
sceglie tra le risoluzioni del Consiglio di sicurezza quelle che
vuole rispettare, invece di esercitare la propria leadership per
ottenere le azioni dell'Onu di cui gli Usa hanno bisogno,
indebolisce un prezioso strumento di politica estera".
I termini del dibattito interno all'establishment riguardo alla
politica da seguire nei confronti delle Nazioni unite sono
dunque ben definiti: utilizzare l'organizzazione à la carte, a
seconda dei bisogni statunitensi, oppure dirigerla in modo
conseguente per fissarne il menu. In un periodo in cui vengono
proposti numerosi progetti di riforma dell'Onu che, senza
l'appoggio degli Stati uniti rimarranno delle vane chimere è
bene ricordarsi cosa Washington vuole fare dell'organizzazione.
note:
*Professore, Università Parigi VIII
torna al testo (1) Nel 1988, 107 stati membri contribuivano al 2% del bilancio,
mentre in 15 ne finanziavano l'84,5%. All'interno di questo
secondo gruppo, il contributo degli Stati uniti era stato
ridotto dal 31,5% al 25% del bilancio nel 1972.
torna al testo (2) L'espressione è di Charles Krauthammer, editorialista
statunitense un tempo molto ostile all'Onu e ormai cinicamente
favorevole alla sua utilizzazione quando questo serve agli
interessi degli Stati uniti.
torna al testo (3) Sul "voltafaccia" degli Stati uniti e, più generalmente,
sull'evoluzione dei loro rapporti con l'Onu fino all'arrivo di
Clinton al potere, cfr. l'eccellente lavoro di Robert W.Gregg,
About Face? The United States and the United Nations, Lynne
Rienner Publishers, Boulder, Colorado, 1993.
torna al testo (4) Graham Allison e Gregory F.Treverton, Rethinking America's
Security: Beyond Cold War to the New World Order, Norton, New
York, 1992.
torna al testo (5) Si è parlato molto dell'opposizione del giovane Clinton alla
guerra del Vietnam, ma molto meno del fatto che, diventato
governatore dell'Arkansas, ha presieduto il Democratic
Leadership Council (blocco dei democratici fuori del Congresso),
favorevole nel 1990 all'intervento militare contro l'Iraq.
torna al testo (6) Il Giappone, una volta di più, è stato il principale
finanziatore dell'intervento in Somalia: 100 milioni di dollari
di contributi (il 91% del totale) al primo fondo specializzato
creato per la forza di intervento unificata.
torna al testo (7) Nel vocabolario del Pentagono, la "sindrome di Beirut"
designa la paura di attentati, come quello che è costato la vita
a 241 "marines" in Libano il 23 ottobre 1983.
torna al testo (8) Gli Stati uniti dovrebbero contribuire per il 30% al
finanziamento delle attività di mantenimento della pace che
comportano la presenza di caschi blu. Chiedono che la loro parte
venga ridotta al 25%.
torna al testo (9) "Going it Alone and Multilateralism Aren't Leadership",
International Herald Tribune, 4-5 febbraio 1995.
(Traduzione di A.M.M.)
Articolo tratto da Le Monde Diplomatique dell'Ottobre-1995, inserto mensile de il manifesto