
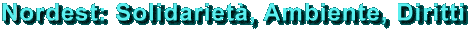 |
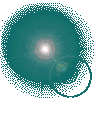 |
|
| Il
territorio e il conflitto
di Marco Revelli Dunque la "bella unità" di Venezia
si è incrinata.
Ancora a Venezia, meno di un anno dopo, alla metà di settembre del '97 - nei giorni della sfida secessionista della Lega - quella galassia discorsiva si era materializzata in mobilitazione dal basso, lasciando intravvedere in filigrana il reticolo di un possibile movimento capace di realizzare quella critica-pratica al capitalismo post-fordista e insieme di radicare forme sia pure embrionali di condensazione e di contropotere, la cui assenza è il vero "buco nero" dell'opposizione sociale in questa fase. Ora, con l'articolo di Beppe Caccia e Luca Casarini (sul manifesto dell'8 marzo) e con la replica di Paolo Cacciari (sul manifesto dell'11 marzo), due delle anime più significative di quel processo ricompositivo, quelle che più si erano impegnate nel cercarne e inventarne sbocchi operativi, rivelano, in qualche modo, una linea di incrinatura. O, quantomeno, l'emergere di una divergenza su uno dei temi di dibattito più caldi nel nord-est: la "federazione dei federalisti" veneti. Mi sembra - lo dico con tutta franchezza - una battuta d'arresto. Di più: un non inevitabile passo indietro. Intanto perché l'adesione all'area dei "catalani veneti" non mi sembra un tema su cui rompere. E nemmeno su cui "litigare a priori". Appartiene al repertorio delle opzioni tattiche, delle scommesse politiche, dei percorsi intermedi, dall'esito incerto, su cui serenamente sospendere il giudizio. Eventualmente sperimentare, misurando vantaggi e svantaggi. Ma non una discriminante dell'identità, sia per chi vi "entra" come per chi ne "sta fuori", come sarebbe invece in una logica che esaurisce la propria sostanza negli schieramenti, che assolutizza le formule organizzative facendone misura dell'appartenenza e facendo dell'appartenenza l'essenza della politica. In una logica cioè da puro "ceto politico". E d'altra parte un po' da "ceto politico" mi sembrano - non se ne abbiano i compagni veneti di entrambe le posizioni - il merito stesso della discussione ed i termini dell'argomentazione, a cominciare dal suo cuore concettuale: il federalismo. Personalmente considero la riduzione drastica del raggio spaziale di riferimento una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il rilancio del conflitto sociale nella sua dimensione materiale, concreta, "reale". Nell'epoca in cui le dinamiche economiche segnano una accelerata territorializzazione del processo produttivo e accumulativo, territorializzare il conflitto diventa una via obbligata per restituirgli "presa" sui processi reali, e capacità di condensazione d'identità e di forza. Fuori da ciò c'è la dimensione ormai sempre più esclusivamente simbolica e virtuale dello Stato nazionale: la forma di una politica sempre più impenetrabile ai movimenti di un "sociale" che dal "centro" - un centro ormai vuoto di materia ma terribilmente esaltato nella propria illusione di onnipotenza - non può che apparire irrimediabilmente periferico, parziale, subalterno. Se per "federalismo" si intende misurarsi con le nuove "geografie della complessità", e tradurne la nuova spazialità in chiave antagonistica, nella capacità di ritrovare un "luogo" del conflitto, dopo che il tramonto del fordismo ci ha privati dei luoghi consolidati - fabbrica e stato -; se con esso significa prendere atto che la nuova fabbrica è il territorio, così come l'"economia di flusso" post-fordista, il reticolo carsico dell'impresa a rete, lo ridefiniscono; se con esso non si intende - come invece nello spirito della bicamerale, e dei tanti neo-autoritarismi regionali - ritrovare un nuovo spazio del comando, ma un nuovo luogo dell'aggregazione e del conflitto, allora io credo che l'opzione federalista - così come viene proposta nella formula "liberare e federare", e tanto più se declinata nel modulo del municipalismo -, sia un passaggio fecondo, e per molti versi obbligato. Questo mi sembra ci ricordino i centri sociali del nord-est. E fanno bene. Nello stesso tempo penso che il territorio sia pieno d'insidie. E di ambiguità. Che la trappola dell'interclassismo, del micro-nazionalismo, del neo-corporativismo territoriale sia pericolosamente pronta a scattare ad ogni passo, dietro ad ogni svolta. Nel raggio breve del territorio il confine tra il "noi" e l'"altro" - dove l'"altro" non è l'ospite che viene da fuori e ci mostra l'universalmente umano, ma è l'alter-ego interno, l'altro "sociale" che parla la stessa lingua e dichiara le stesse origini "etniche", e ci sottomette - è terribilmente stretto. E fragile. Se il conflitto verticale - quello positivo, sano, tra basso e alto, tra dominati e dominanti, tra comando e resistenza - non opera costantemente come fattore di chiarificazione, come anticipo e stella polare, allora l'alternativa inevitabile è l'oscena unità d'interesse locale contro ciò che sta fuori: è la distruttività sociale del conflitto orizzontale, che separa ciò che dovrebbe essere unito e unisce ciò che dovrebbe essere separato. Questo mi pare ci ricordi Paolo Cacciari. E non può che giovarci. Quello però che stento a capire è perché poi lo stesso Paolo Cacciari, sensibile, acuto, non certo sospetto di "centralismo", tenda ad escludere con tanta inappellabilità che "la lotta per la liberazione dalla condizione di sfruttamento e di alienazione di occupati e disoccupati, e per allargare i loro spazi di democrazia e di autogoverno, possa trarre qualche vantaggio" da quella che liquida come "vulgata federalista", ignorando l'altro "corno" del problema (la forza di un'opzione anti-centralista); e perché Caccia e Casarini, veterani dell'antagonismo, a loro volta non certo sospettabili di tentazioni interclassiste, proclamino, con la stessa sicurezza, che il movimento federalista del nord-est a cui hanno appena aderito è "l'unico soggetto politico in grado di fornire una risposta credibile ed efficace di fronte alla barbara prospettiva del secessionismo", glissando sulle componenti meno presentabili di esso (che pure un po' di problema fanno). Chiedo a tutti loro: non c'è in questo modo di argomentare un po' dell'antica pratica di "ceto"? Quel mettere bandiere su qualche casamatta (la propria, di raggio più o meno ampio) fingendo che sia l'ultimo e l'unico bastione? Quell'assolutizzare il dettaglio tattico (l'opzione organizzativa), per farne fondamento di un'identità strategica non verificata nel concreto gioco dei soggetti collettivi? Vorrei che si parlasse più delle pratiche di "liberazione e federazione" nel nord-est, che non delle vicende organizzative dei nostri amici nella regione. Più del conflitto che entrambi pure invocano, che non dei contenitori in cui si rinchiudono. La politica, ogni giorno me ne convinco di più, fa male. Enfatizza i dettagli, occulta la sostanza, sollecita l'orgoglio del Sé; soprattutto, riduce il campo del possibile ai limiti stretti delle proprie risorse organizzative. Venezia era diventata un buon luogo termale, per curarsene. Vi prego, non scriveteci sopra "chiuso per restauri". |